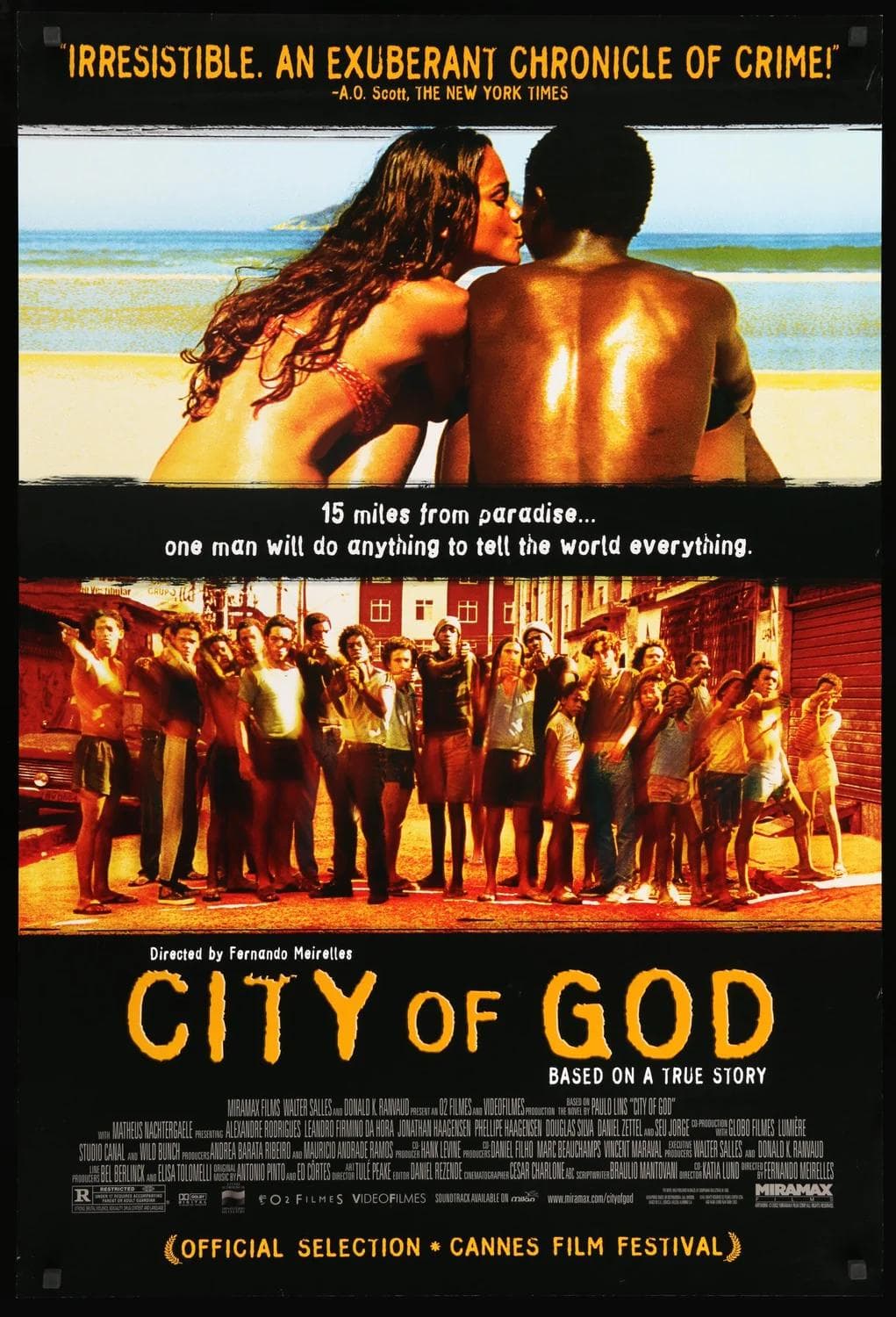
La Città di Dio
2002
Vota questo film
Media: 0.00 / 5
(0 voti)
Registi
Un’opera violenta e diretta, sorprende per il suo crudo realismo ma anche per l’interpretazione dei giovani attori, tutti rigorosamente non professionisti. Questo "crudo realismo" non è una mera scelta stilistica; è una dichiarazione d'intenti, un imperativo morale che affonda le sue radici tanto nel Neorealismo italiano quanto nel Cinema Novo brasiliano, movimenti che hanno cercato di restituire la verità nuda e cruda delle realtà sociali, spesso con intenti di denuncia politica. La scelta di attori non professionisti, reclutati dalle stesse comunità che compongono la trama, non è solo un accorgimento di casting, ma un atto radicale che dissolve i confini tra finzione e vissuto, infondendo ogni gesto, ogni sguardo, di una veridicità quasi documentaristica, irriproducibile da attori di mestiere, per quanto talentuosi.
È un romanzo di formazione che narra la storia di due ragazzi che crescono nell’ambiente cruento e maledetto della Città di Dio, labirintica favela ai margini di Rio de Janeiro. Lungi dall'essere un semplice fondale, la Cidade de Deus emerge come un personaggio a sé stante, una mostruosa entità urbana fatta di lamiere ondulate, mattoni e una disperata, tenace resilienza umana. I suoi vicoli labirintici sono arterie soffocanti, intasate da sogni infranti e speranze calpestate, un ecosistema chiuso dove le leggi del mondo esterno si annullano, sostituite da un ordine brutale e auto-imposto. Questo "non-luogo" diventa un crogiolo che forgia destini divergenti non tanto per libera scelta, quanto per il peso schiacciante delle circostanze.
Buscapè vuole andarsene da quel non-luogo, la sua aspirazione è diventare fotografo professionista. La sua macchina fotografica non è solo uno strumento, ma uno scudo e un passaporto. Gli offre un punto di osservazione privilegiato, un ruolo di testimone distaccato in un universo dove il distacco è un lusso quasi impensabile. Attraverso il suo obiettivo, il caos della favela viene incorniciato, reso intelligibile, persino intrinsecamente affascinante nella sua cruda realtà. La fotografia diventa la sua voce, la sua agenzia, un sottile atto di ribellione contro la narrazione di violenza che minaccia di inghiottirlo. Egli cerca di catturare la realtà, non di esserne vittima, trasformando l'osservazione in una forma di salvezza e riscatto personale.
Dadinho è un ragazzino fagocitato da quella spirale di violenza e divenuto complementare alla logica di sopraffazione che impera tra i vicoli della Città di Dio. La sua trasformazione in Ze Pequenho, giovane boss del narcotraffico, capo incontrastato della criminalità locale, è una discesa agghiacciante nel cuore delle tenebre, un monito desolante su come l'innocenza infantile possa essere irrevocabilmente corrotta da un ambiente privo di ogni barlume di speranza. La sua evoluzione è meno una scelta che un'ineluttabilità, un esito logico – seppur terrificante – di un sistema che premia la brutalità e castiga la vulnerabilità. Zé Pequenho incarna la massima espressione del distorto contratto sociale della favela: la forza è legge e il potere è esercitato attraverso il terrore. Il suo regno è uno stato totalitario in miniatura, un microcosmo di potere assoluto che prospera nel vuoto lasciato dall'abdicazione statale. I suoi metodi violenti causeranno molto presto una guerra tra bande dai risvolti tragici. La sua violenza patologica non è casuale; è una performance meticolosamente costruita per cementare la sua autorità ed eliminare il dissenso, una perversa forma di ingegneria sociale.
Accortissima la mano del regista nel riesumare davanti ai nostri occhi l’aura e la carnalità di una gioventù travolta dall’ambiente, dalla sporcizia di ideali calpestati e travolti, da una miseria che catalizza una darwiniana voglia di emergere. Fernando Meirelles e Kátia Lund orchestrano questa epopea di sopravvivenza con un dinamismo mozzafiato che rispecchia la frenetica energia della favela stessa. Il montaggio serrato e virtuosistico di Daniel Rezende, spesso citato come rivoluzionario, non si limita a far progredire la trama; ci immerge in un sovraccarico sensoriale, nella minaccia costante, nei fugaci momenti di gioia e disperazione. La cinematografia vibrante e spesso inondata di sole di César Charlone, paradossalmente, rende la miseria quasi sublime, evidenziando il crudo contrasto tra la bellezza naturale del Brasile e la bruttezza creata dall'uomo delle sue disparità sociali. Questa esuberanza stilistica, tuttavia, non distoglie mai dal messaggio centrale del film: una profonda accusa a una società che permette a tali condizioni di proliferare, dove le vite umane sono merce sacrificabile in un mercato della disperazione.
Una dimensione dove ogni giudizio morale viene congelato e dove ogni azione dei protagonisti è governata o piegata da una bieca disumanità che sommerge ogni altro risvolto etico. Il film rifugge ogni facile moralismo, costringendo invece lo spettatore a confrontarsi con la logica brutale che sottende le azioni dei personaggi. È una visione in cui l'etica non è semplicemente sospesa, ma attivamente capovolta, dove la sopravvivenza stessa diventa la virtù ultima, e spesso l'unica. Questo deserto etico, scolpito da generazioni di incuria sistemica, pone un interrogativo terrificante: cosa accade quando le fondamenta stesse della dignità umana vengono erose fino alla polvere?
Una delle scene più emozionanti è sicuramente l’uccisione di un bambino della Favela colpevole di aver rubato del pane dalla tavola di Ze Pequenho. Questi con un divertito senso della giustizia lo fa uccidere dal più giovane ragazzino della sua banda per insegnare agli altri come ci si deve comportare in sua presenza. Questa scena, in particolare, è un pugno nello stomaco, un momento di profonda abiezione morale, un rito di iniziazione non solo per il più giovane sicario ma per lo spettatore all'assoluta mancanza di redenzione della favela. Il tutto viene filmato con un terrificante e disincantato realismo che ricorda il Pasolini di Accattone, non solo per la cruda rappresentazione del sottoproletariato violento, ma per il suo peso allegorico. Come Pasolini nelle sue cronache del lumpenproletariat romano, "La Città di Dio" si addentra in un mondo abbandonato dalla società ufficiale, dove emergono nuovi, brutali codici. Ma mentre Pasolini spesso infondeva il suo realismo con un'aura tragica, quasi sacra, Meirelles presenta una realtà spogliata di ogni romanticismo, un universo dove il sacro è stato rimpiazzato dal profano, dove l'innocenza è una debolezza e la crudeltà una necessaria abilità di sopravvivenza. Lo sguardo impassibile della macchina da presa, molto simile a quello di un documentario, cattura l'orrore senza editorializzare, invitandoci a essere testimoni piuttosto che a giudicare da lontano. Questa onestà senza compromessi trova echi in una variegata genealogia cinematografica, dal realismo sociale di Ken Loach alle grintose cronache urbane del primo Scorsese, eppure "La Città di Dio" si ritaglia un proprio spazio unico, infondendo questo iperrealismo con un'energia cinetica, quasi allucinatoria. È una visione che riesce a essere al tempo stesso epica nella sua portata e intimamente terrificante nella sua attenzione al costo individuale del collasso sociale.
Featured Videos
Trailer Ufficiale
Commenti
Loading comments...